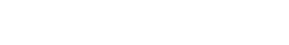Steinheim – 3B Scientific Anthropological Skull Model - Steinheim User Manual
Page 12

®
Italiano
Steinheim
• Homo steinheimensis (Berkhemer 1936)
• Homo sapiens steinheimensis (Campbell 1964)
• Gruppo: Pre-neandertaliani (ante-neandertaliani) evtl. Homo sapiens arcaico
• Ricostruzione in base al cranio di Berkhemer senza mandibola
Questo modello è il calco di una riproduzione proveniente dalla raccolta dell’università Johann Wolfgang
Goethe di Francoforte sul Meno, Istituto di antropologia e genetica umana per biologi.
Il cranio è stato scoperto nel 1933 in una cava di ghiaia nelle vicinanze di Steinheim an der Merz (in
Germania meridionale). Negli stessi strati si sono trovate ossa di elefanti antichi, di rinoceronte di Merck e
di cervo gigante a corna larghe, cosicché per via di questi reperti concomitanti è stata possibile una data-
zione approssimativa (pleistocene medio superiore). In seguito è stata eseguita anche una classificazione
esatta che ha stabilito un’età di circa 250.000 anni.
Il cranio di Steinheim appartiene quindi all’ultima parte dell’era interglaciale di Mindel-Riss; ne consegue
che è molto più vecchio del neandertaliano classico e anche del preneandertaliano, ma molto più giovane
del Sinanthropus (Homo erectus pekinensis) e persino dell’uomo di Heidelberg (Homo erectus heidelber-
gensis).
Nel cranio originale, appartenente ad un individuo di circa 25 – 35 anni, mancano per esempio parti della
mascella superiore con i denti anteriori, mentre le due arcate zigomatiche e il lato sinistro del viso presen-
tano forti lesioni. Il lato destro del cranio sembra meglio conservato, anche se probabilmente la pressione
della terra sovrastante ne ha determinato il lieve spostamento verso sinistra, per cui si rendono necessarie
alcune correzioni al fine di arrivare ad una classificazione e ricostruzione precisa del cranio.
Per quanto riguarda la forma esterna, si notano somiglianze con il cranio dell’uomo recente soprattutto
nell’andamento della curva sagittale della regione craniale posteriore, ma anche nella curva trasversale
con andamento “a cinque angoli”. La dentatura è già fortemente ridotta e i denti della mascella superiore
sono completamente simili nella forma a quelli dell’uomo recente. I molari superiori (“denti del giudizio”)
sono molto più piccoli degli altri due molari, il che ci porta a supporre una mandibola relativamente pic-
cola, di ampiezza molto inferiore a quella del neandertaliano classico.
Il cranio, molto stretto rispetto a quello del neandertaliano classico e anche del Sinanthropus; è inoltre
caratterizzato da una fossa canina sull‘osso della mascella superiore, sotto la cavità oculare, e da un avval-
lamento profondo della radice nasale. Il viso non è molto sporgente (proscopinia ridotta) e le ossa del
cranio non sono così spesse come nel neandertaliano classico. La larghezza massima della calotta cranica
non è più nella regione delle orecchie, come nel Sinanthropus, bensì molto più in alto. Il cranio è comples-
sivamente più alto e manca anche lo stacco netto dell’occipite, che osservato da dietro presenta una forma
quasi quadrata. Il processo mastoideo dell’osso temporale tuttavia è straordinariamente piccolo.
La lunghezza del cranio è di 185 mm, la larghezza di 132 mm, il volume della calotta cranica è di 1100
- 1200 cm3. Si tratta quindi di un cranio relativamente lungo, ma molto stretto e nel complesso minuto.
Sulla base della “diagnosi complessiva”, Weinert (1936) ritiene che il cranio sia femminile. Questa tesi è
però contraddetta dall’andamento della fronte, dalla forma della cavità oculare e della regione sopraorbi-
tale, dalla regione gabellare e dallo sviluppo della prominenza sopraorbitale.
Il cranio di Steinheim ha ispirato per molto tempo la cosiddetta „teoria del Presapiens“, secondo la quale
l‘uomo anatomicamente moderno e l‘uomo di Neandertal si sono sviluppati contemporaneamente in
Europa. Anche se il cranio di Steinheim pone tuttora notevoli interrogativi per via del suo sconcertante
mosaico di caratteri moderni ed arcaici, la „teoria del Presapiens“ in questa forma non è più sostenibile.
Il cranio va collocato quale rappresentante femminile nell’ambito dei reperti dell‘Homo heidelbergensis o
del primo uomo di Neandertal.